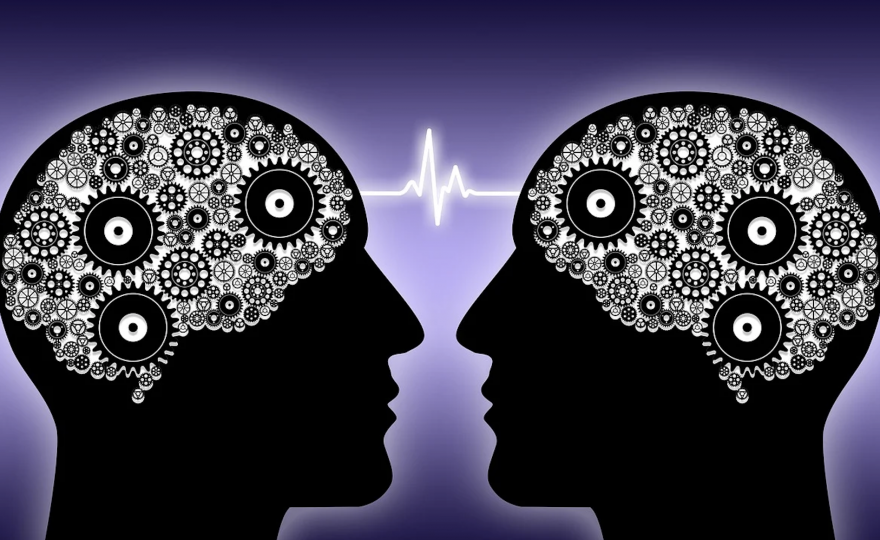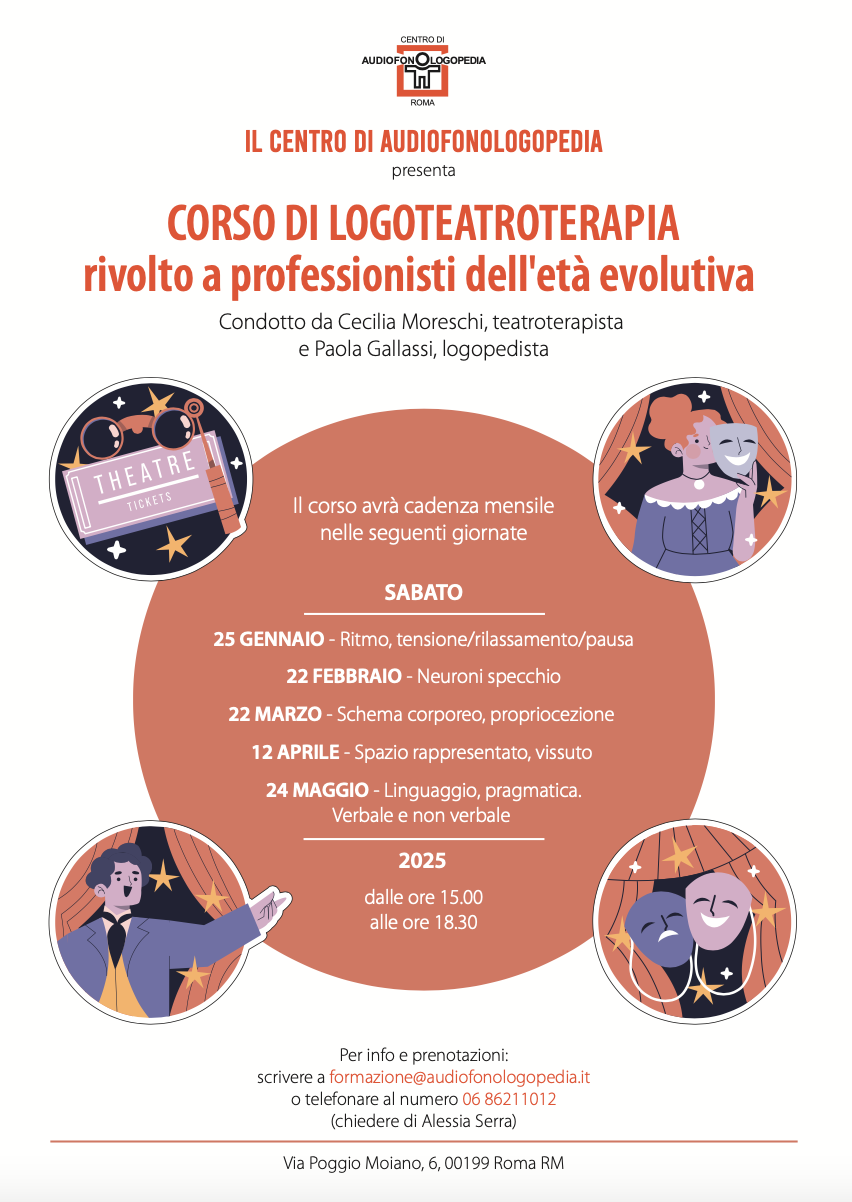Nei laboratori teatrali dedicati all’età evolutiva condotti presso istituti scolastici (ma anche in associazioni teatrali specializzate nel lavoro con bambini e ragazzi, oratori parrocchiali, cooperative sociali...) trascorrono veloci le settimane di creazione della messinscena e delle prove in cui ogni singolo elemento viene limato, perfezionato, anche eliminato se necessario.
Noi registi, docenti o animatori teatrali stimoliamo gli allievi a integrare tutti gli apprendimenti lavorati nei mesi o anni precedenti: la propriocezione, il corpo nello spazio, la relazione con l’altro, il personaggio, l’espressione, la voce, il gesto associato alla battuta, la memoria, il problem solving, e tanto altro ancora.
I ragazzi si aiutano gli uni con gli altri, prestandosi oggetti e indumenti o suggerendo le battute dimenticate. Lavoriamo tutti alacremente, persino i genitori sono spesso coinvolti nel cucire l’abito adatto o dipingere un pannello della scenografia. E che dire dei docenti? Si spendono generosamente, andando oltre il proprio orario di lavoro, controllando che tutto sia perfetto, stimolando ciascuno degli allievi a tirar fuori il meglio di sé, a restare concentrato sull’obiettivo da raggiungere non facendosi distrarre da elementi o informazioni non pertinenti, e (anche qui) tanto altro ancora.
Add a comment